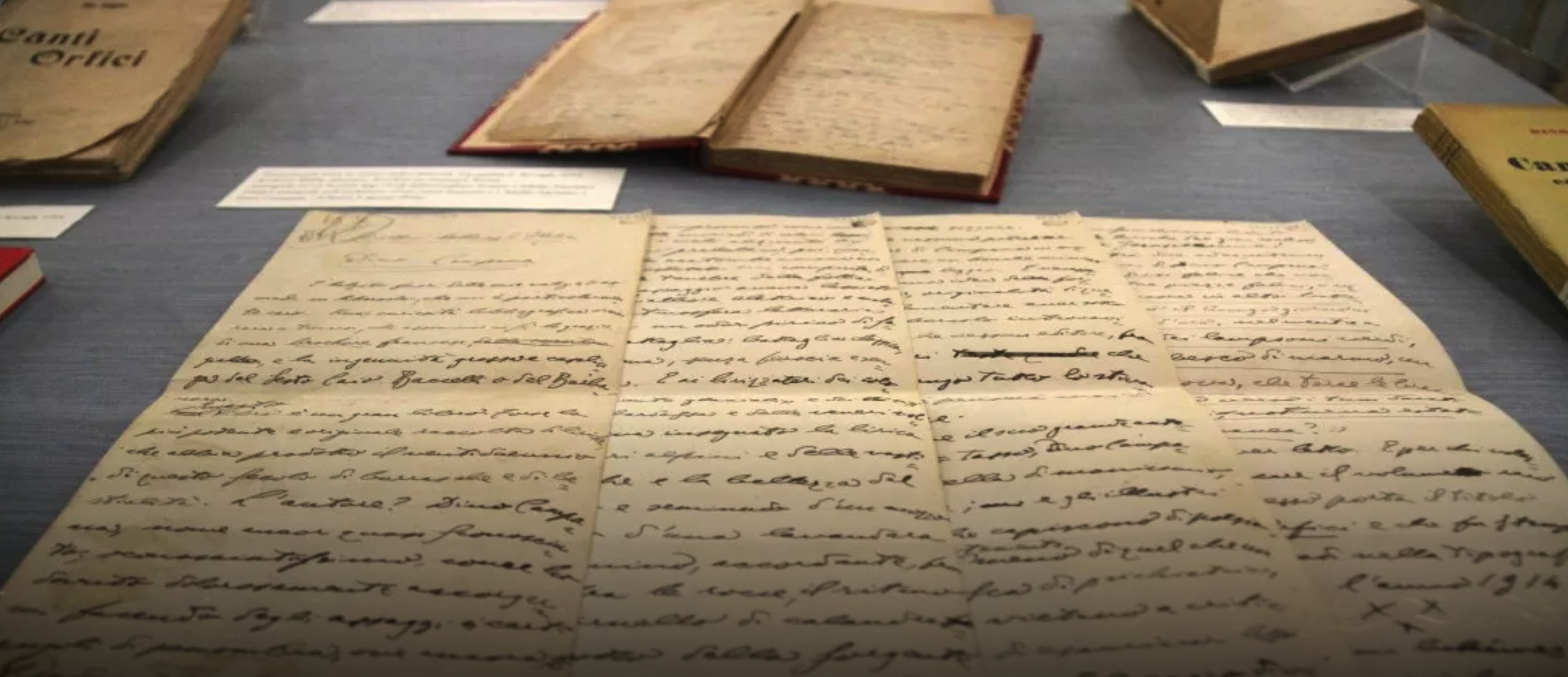Il problema dell'allegoria in Campana
di Francesco Muzzioli
1. Alcune questioni preliminari
II riconoscimento dell’allegoria in Campana deve affrontare, preliminarmente, almeno tre generi di questioni; la discussione con la tradizione critica che vede in Campana non l’allegoria ma il simbolo; la ricerca delle indicazioni dell’autore sulle quali basare una lettura in chiave allegorica; la necessità di specificare quale tipo di allegoria sarebbe - eventualmente - presente in Campana.
Procediamo per ordine:
Nella storia della critica campaniana è comune la collocazione del poeta degli Orfici nell’ambito del simbolismo e come antecedente dell’ermetismo ungarettiano. Anche la corrente che esprime riserve su un suo presunto eccesso di retorica letterarietà, rifiutandogli il raggiungimento di un simbolo plasticamente rilevato e essenzialmente vissuto, gli concede pur sempre il risultato di un simbolo vago e distanziante.
Tra le principali monografie, quelle della Del Serra e di Bonifazi sono nettamente schierate pro symbolo, sia pure in diverso modo e grado. Bonifazi è il rappresentante di una teoria del simbolo d’abord et toujours, che non si ferma davanti ad alcun ostacolo; e in cui il termine simbolo è usato come «chiave universale», in una vasta gamma di occorrenze, da solo o insieme ad altri (così troviamo i «simboli dell’eternità», i «simboli del mito», o il «simbolo del mistero»; e ancora, in un elenco indifferenziato, «paesaggi di simboli, enigmi e ancora misteri»); basta che indichi la via della smaterializzazione della realtà concreta attraverso l’immagine, dell’incielarsi della «trasfigurazione iniziatica» e della «azione sublimante».
Diverso e più articolato è il caso della Del Serra. Anche se la sua lettura dell’itinerario di Campana perviene a una non meno "mistica" elevazione, questa è vista, almeno, come processo problematico, nel quale processo è dato - cosa che interessa il nostro argomento - un posto all’allegoria.
Nel suo studio maggiore, la Del Serra ordina la produzione campaniana in tre fasi caratterizzate proprio dal progressivo superamento dell’allegoria che sarebbe presente, quindi, come una sorta di residuo, di zavorra gradualmente smaltita nell’ascesa verso il «gioioso abbandono simbolico».
Trionfa qui, ancora una volta, il pregiudizio romantico-idealista che considera l’allegoria un segno "convenzionale" ed inerte. Nelle pagine critiche della Del Serra, il simbolo appare ricco e polivalente, l’allegoria poveramente univoca; l’allegoria non sarebbe altro che un simbolo "decaduto" (sclerotizzato, fissato, ridotto), e in questa connotazione negativa, includerebbe tutto il "non risolto", tutto ciò che non ha raggiunto la «resa lirica».
L’allegoria così intesa darebbe vita, dunque, a una contraddizione interna alla poesia di Campana che verrebbe risolta felicemente, nel Campana "maturo", in favore della sintesi e della fusione del simbolo.
Abbiamo qui due posizioni diverse, ma tutte e due guidate da un partito preso a favore del simbolo. Chi volesse - nella polarizzazione moderna che oppone simbolo ad allegoria - prendere partito per la "forma di espressione allegorica", dovrebbe considerare la possibilità di ribaltare diametralmente questo tipo di interpretazioni. Tuttavia, ad un attento esame, una simile operazione "sostitutiva" appare insufficiente.
Ribaltare Bonifazi significherebbe scoprire dietro a tutti i simboli indicati (la torre, la notte, lo specchio, ecc.) altrettanti rimandi allegorici - gioco di abilità facile quasi quanto il precedente. Ribaltare l’ottica della Del Serra, significherebbe si vedere come positiva la presenza dell’allegoria e anche la contraddizione da essa prodotta; ma se si conservasse la periodizzazione che sfocia nell’affermarsi del «simbolo di sintesi», non resterebbe altro che deprecare lo sviluppo di un autore che va infine perduto all’istanza allegorica.
Né è conveniente strappare alla damnatio, così com’è, una nozione di allegoria come staticità univoca del significato. Ora, andare oltre un semplice ribaltamento comporta l’affrontare gli altri due generi di questioni. E continuiamo con:
b) Un punto da chiarire, quando si parla di allegoria, è se si stia facendo riferimento ad essa come esegesi interpretativa o come modo di espressione. Nel primo caso, non sarebbe necessario supporre alcuna intenzionalità dell’autore; il senso nascosto è "trovato" dall’interprete che è vincolato unicamente alla coerenza della propria "invenzione". Il che non può garantire dalle forzature del come-volevasi-dimostrare: la tradizione greca e cristiana dell’esegesi allegorica mostra che quanto di esorbitante il testo presenta rispetto alla presupposizione dell’interprete può essere ridotto a colpi di allegoria. L’allegoresi sembra inarrestabile quanto arbitraria; «Tutto per lei diviene allegoria» si potrebbe dire, parafrasando Baudelaire. Corollario: se l’allegoria fosse tutta negli occhi del soggetto interpretante, qualsiasi testo diventerebbe allegorico e quindi non sarebbe più possibile tracciare una contrapposizione tra simbolo e allegoria; l’antagonismo tra i due, in quanto modi di significare, è pensabile solo se esso promana dagli oggetti testuali e la critica non lo inventa, ma lo "espone".
Per fondare l’esegesi nel testo, però, bisogna vedere nell’allegoria un modo di espressione: e ipotizzare un allegorista che progetta e costruisce il testo in una data maniera, guidato da una certa intenzionalità. Tuttavia il richiamo all’intenzionalità non manca di sollevare, a sua volta, una quantità discretamente grave di problemi: si obietterà che allora al critico non resterebbe altro che rintracciare quel contenuto segreto nascosto dall’autore nel testo. Nel caso fosse l’autore stesso a rivelarlo, l’interpretazione sarebbe finita ancor prima di cominciare. (E poi: come difendere in tal caso l’allegoria dall’accusa crociana di essere mera criptografia?).
È probabile che la questione vada risolta in modo dialettico. Ma in attesa di concentrare la riflessione su questo punto, in una successiva occasione, basti per ora fermarsi sulla necessità di non escludere il riferimento all’intenzionalità. Le intenzioni non saranno decisive e insindacabili, ma nemmeno possono essere trascurate.
Lo stesso Benjamin, del resto, nello studio sul Dramma barocco parla molto spesso di «intenzione allegorica». Al momento, sarà sufficiente non evitare queste semplici domande: nell’autore in esame, ci sono intenzioni dichiarate, e quali sono? queste espressioni sono compatibili con il modo di espressione allegorico?
Si discute quindi di "intenzione" come orientamento costruttivo e indirizzo progettuale, e non come "chiave" risolutiva. Ma si badi che, nel periodo tra Otto e Novecento, quando ormai nella koinè letteraria era invalsa una versione riduttiva dell’allegoria, questa «intenzione» poteva anche manifestarsi nell’indifferenza o nel ripudio dell’allegoria stessa. Si tratta, perciò, di valutare se le formule propositive degli autori di quel periodo contengano «intenzioni» affini o congruenti a quelle che oggi siamo in grado di definire come consone all’allegoria "moderna".
È questo il caso di Campana, il quale non parla mai direttamente di allegoria.
E tuttavia sembra plausibile ritenere che egli non intenda la sua "rappresentazione" poetica come fine a se stessa, ovverosia limitata a un significato descrittivo, mimetico o impressionistico. Campana fa un uso "figurativo" della parola: compone immagini («figure», «figurazioni») che rimandano a un senso ulteriore.
Ma questo «quadro» che la poesia tratteggia con i suoi segni verbali, non è ancor detto che sia un’allegoria. Le immagini particolari potrebbero benissimo suggerire, evocare, implicare intuitivamente un senso universale che sarebbe perciò simbolico. Tuttavia, il fatto che Campana parli di un duplice piano della «figurazione», fa propendere già verso la discrasia di significante e significato, propria del discorso allegorico.
Ma c’è di più. In alcuni passaggi del Quaderno, Campana allude chiaramente a un senso nascosto che salterebbe fuori dai guasti, dalle sconnessioni, dai "buchi" di una superficie formale che non può più essere quella levigata e armonica della bellezza classica. Se qualcosa traspare che prima era segreto, è dalle distorsioni, dalle rotture e frammentazioni, dalla disorganicità delle forme. "Miseria della poesia": qua sono gli strappi e le lacune dell’abito, là è un «sonetto con le gambe storte» ad indicare dietro l’apparenza, una sostanza di «cose peregrine e rare».
I segnali dell’allegoria sono qui, già, più vicini. Ma ancor maggiore vicinanza - e quasi intera coincidenza, ormai - mostra l’intenzione poetica di Campana con l’’intenzione allegorica", nei frammenti programmatici; e soprattutto in quello che dice:
Nel giro del ritorno eterno vertiginoso l’immagine muore immediatamente.
Da cui si vede che: l’immagine è costretta a ritornare, a presentarsi più volte, e ciò dimostra la caduta del suo potere evocativo, al quale basterebbe una puntuale e momentanea apparizione; il ritornare dell’immagine apre una sorta di vortice "vertiginoso" in cui il senso sprofonda; e in cui si annullano tutte le valenze positive e le euforiche e sublimanti virtù, in uno stato di negativa "mortalità".
L’immagine si trova dunque messa in una situazione critica. La "morte" che il ritorno le promette equivale a quell’«elemento costernante» che Benjamin, in sede di Dramma barocco vedeva come inerente all’essenza dell’allegoria. L’allegoria, benjaminianamente intesa, abita le rovine, diffonde l’oggettivazione "cosale", si «esprime significativamente» nella
«facies hippocratica della storia». In attesa di chiamare a testimoni i testi, l’aforisma programmatico sopra citato dà già la misura di una possibile consonanza.
Naturalmente i fautori del simbolo hanno piegato dalla loro parte anche la morte dell’immagine. La Del Serra, pur non rigettando l’interpretazione "negativa" del motto campaniano, però le accosta come ugualmente valida (e sarà dunque un’ambiguità "indecidibile"?) quella contraria, restituita al "positivo".
Per essa, a morire sarebbe il significato empirico dell’immagine (il livello "letterale-materiale"), con conseguente liberazione del suo afflato simbolico. Ma i conti non tornano: Campana infatti non parla di uno spezzarsi del legame dell’immagine con la realtà, ma di un morire dell’immagine tout court; inoltre ciò avviene nel ritornare dell’immagine e quindi presuppone una doppia presentazione; mentre il simbolo salverebbe l’immagine simultaneamente nel suo presentarsi primo.
Ma soprattutto è decisivo riflettere che il simbolo non porterebbe la morte, ma semmai - come è evidente dalle origini della teoria simbolista, fin da Goethe - una "reviviscenza". Ragion per cui quella che appare piuttosto nettamente una violenta "caduta a picco" è da mettere in conto all’«irrigidirsi semantico del segno»11 proprio dell’allegoria.
Insomma: l’intenzione campaniana di imprimere un movimento circolare (dialettico) dall’insorgere all’annientarsi dell’immagine e il conflitto di significati che ne deriva sono imparentabili con la «contraddizione» e il «ribaltamento» colti da Benjamin nel procedere dell’allegoria.
Questa dinamica espressiva fuoriesce dai connotati di rigidità che una certa tradizione favorevole al simbolo ha assegnato all’allegoria. La damnatio storica dell’allegoria si è fondata su una formulazione riduttiva di questa pratica: o come un senso aggiunto dall’esterno a una lettera che potrebbe farne a meno; o come un senso rivestito di un ornamento che può essere tranquillamente tolto.
In entrambi i casi, l’allegoria è vista come un segno "univoco" che comporta un "significato determinato". Come un’immagine morta in partenza. Abbiamo visto, invece, che per Campana l’immagine muore nel vortice del ritorno: ammesso e non concesso che mai sia stata così statica come la si dipinge nell’epoca dell’egemonia del simbolo, di certo l’allegoria moderna si presenta (e in particolare nell’opera campaniana) nella complessità di una «scrittura in movimento».
E abbiamo raggiunto il terzo livello problematico individuato all’inizio:
c) La ridefinizione dell’allegoria. L’allegoria va strappata alla tradizione a lei avversa, che ne ha fatta una caricatura, limitandone in sostanza il raggio di azione al solo procedimento della "astrazione personificata". L’estetica idealista (e segnatamente Hegel, cui si deve il rimprovero di «freddezza» entrato poi nel senso comune) è la responsabile di questa riduzione, cui Benjamin è riuscito a sottrarsi appoggiandosi, al di qua dei grandi romantici, ai minori del barocco. Benjamin ha affermato la dialetticità dell’allegoria.
Lo stesso sviluppo progrediente dell’allegoria che la distingue dall’istantaneo "fulmine a ciel sereno" del simbolo, non è una qualsiasi linearità di tipo genericamente epico o narrativo; deve essere la risultante di un «movimento dialettico» che «impetuosamente imperversi». All’allegoria pertiene, secondo Benjamin, un «principio dissociante» che polarizza le parti disponendole secondo una tensione di estremi, e producendo con questa contraddizione una successione che ogni volta ribalti i propri esiti, nella «ritmica intermittente di un costante indugio, del repentino rovesciamento e di un rinnovato pietrificarsi».
La stessa convenzionalità addebitata, nella cattiva fama, all’allegoria non deve essere né rifiutata né accolta, quanto piuttosto ricompresa nella dialettica di «convenzione» e «espressione».
Non solo le qualità astratte vestono panni di personaggi o si rapprendono in oggetti; ma anche inversamente gli oggetti concreti e le presenze più comuni e meno considerate assumono valore di portatori di significato. La via maestra dell’allegoria moderna è mostrata da Baudelaire nello sconfinamento tra interiorità ed esteriorità, nel testa-coda tra alto rango e basso rango, tra «significato spiritualizzato» e «sordida quotidianità». Non sarà difficile scoprire che Campana si è mosso proprio lungo questa via.
A chi volesse contenere le influenze baudelairiane nelle «pose schife» della fase preparatoria affidata al Quaderno, fase che sarebbe poi superata nell’atmosfera più rarefatta e sublimata degli Orfici, si può rispondere reinterpretando i periodi dell’itinerario campaniano alla luce della nozione di allegoria sopra accennata.
I Canti orfici - questa è l’ipotesi che cercherò di dimostrare sui testi - non sono una svolta sostanziale rispetto alle "prove" inedite, quanto semmai uno sviluppo capillare e di ulteriore complessità di quei "movimenti dialettici" già avviati in sede di Quaderno.
E quanto più quei movimenti sono calati internamente alla costruzione del "libro", e cioè nella sua complessa strategia di "ritorni", tanto più Campana può permettersi - di qui l’apparente attenuazione di certi temi "maledetti" - di tagliare le punte più evidenti e di fare a meno delle chiavi troppo esplicite.
Lasciando che sia il contesto nel suo insieme a conseguire il sistematico "svuotamento" di ogni impressione gratificante di "pienezza".
2. Agli estremi del «Quaderno»
«II tempo miserabile consumi» e «Dall’alto giù della china ripida» sembrerebbero i rappresentanti esemplari di due movimenti antitetici (e la suggestione aumenta per il fatto che essi si trovano agli antipodi, uno all’inizio, l’altro alla fine del Quaderno). Da un lato, il primo si svolge nell’arco di una invocazione alla morte, che viene personificata ed interviene come "agente demonico"; dall’altro lato, l’ultimo prende spunto da un avvenimento quotidiano dandogli veste letteraria ed alzandolo al livello di significati «superiori».
Se ritenessimo con Frye (che dal canto suo ha alle spalle una autorevole tradizione) che l’allegoria procede dall’astratto al concreto e il simbolo viceversa dal concreto all’astratto, sarebbe allora facile correre alla semplificazione e vedere agli estremi del Quaderno, rispettivamente l’allegoria e il simbolo. Ma a parte il fatto che probabilmente pochi testi, in generale, si adattano a uno schema del genere, sicuramente vi sfugge una allegoria quale è quella praticata da Campana.
Anche ammesso che Campana, ai due estremi del Quaderno, abbia preso le mosse in un caso da un’idea astratta e nell’altro da un episodio concreto, l’andamento di entrambi i componimenti è tale da stabilire tra l’astratto e il concreto un rapporto complesso e contraddittorio, tutt’altro che rappresentabile nei termini di un percorso dall’uno verso l’altro.
«Il tempo miserabile consumi» si fonda sulle personificazioni (care alla tradizione barocca) del tempo e della morte. In particolare la morte viene invocata nei termini dell’iconografia corrente come «pallida» e «magra». La stessa ripresa citazionale del Voyage di Baudelaire («O morte o morte vecchio capitano / Ischeletrito») ottempera più di quanto non faccia la fonte alla usuale rappresentazione della morte come scheletro. Ma, intanto, notiamo subito che i connotati "obbligatori" della convenzione vengono esibiti tutti e quasi affastellati, producendo una troppo rapida trasformazione dell’immagine: quelle che dovrebbero essere (nel «capitano ischeletrito») articolazioni ossee diventano (per via del fatto che la morte impugna la falce) «falcate braccia», e immediatamente dopo (per contagio col materiale della tomba) braccia di marmo.
Non solo: l’abbraccio della morte dovrebbe condurre, nella stereotipa versione da memento penitenziale, verso il basso della dannazione; qui invece punta verso l’alto, con il caricamento della tensione in una - molto moderna, e baudelairiana - sovreccitazione cerebrale:
(...) e portami in stretta disperataVerso le stelleO muto e cieco reduce, tra il marmoDelle tue braccia suoni la mia testaEletrizzata esausta come cordaChe si dirompe.Questo il finale. Ma proprio l’esito che modernizza, e ribalta infine il conformismo degli elementi adoperati, spinge a rivedere l’insieme. L’invocazione alla morte prende il tenore di un ammonimento tutto terreno, che vale da estremistico rifiuto del modo di vita borghese, poiché la solidità rassicurante dei borghesi si fonda proprio sulla sua rimozione («Ma il mondo grasso l’ha scomunicata / E la disprezza»).
Venga dunque la morte (questa la parafrasi dell’iniziale invito alla "consumazione") piuttosto che l’integrazione sociale, con il suo gusto "avvelenato" e la sua estetica del "grazioso" ridotta a languido esercizio postprandiale («Un dopopranzo, sdraiato sull’erba / pieno di cibi e di languore anch’io / [...] / Avrei fatto dei versi deliziosi»).
Come emerge in un altro punto del Quaderno, la morte è l’emissario della «distruzione»; è il necessario esecutore della condanna di una classe dirigente portatrice di degenerazione e rovina. Anche nel testo che stiamo considerando la rappresentazione di una società opprimente dove
I ricchi son potenti al giorno d’oggi
fanno le leggi e decretan la fame20
occupa il corpo centrale della composizione. In essa le astrazioni personificate (ad esempio l’ideale che appare «emaciato e affievolito») si intrecciano e fanno i conti duramente con le entità collettive: i ricchi, e poi le donne, i bruti, i pazzi.
In un quadro dove, tra l’altro, le proteste solamente verbali risuonano come prive di efficacia, risibili e emarginate («ai loro tuoni di teatro buffo / Rispondono profondi / I gravi rospi e le ranocchie tenere»). Dallo scontro tra astratto e concreto, che si riproduce nello scontro tra individuo e collettività (non per caso l’ideale è personificato: perché esso ormai risiede nella singola persona isolata e sconfitta), sorge quindi la complessiva allegoria della palus putredinis sociale.
E, in questa luce, non è del tutto escluso che l’aggettivo «miserabile» dell’abbrivio («II tempo miserabile consumi / Me, la mia gioia e tutta la speranza») sia da riferire non già o non solo all’io nella sua caducità, ma al tempo: al tempo allora indicato, oltre la pura cronologicità del suo decorso, come epoca storica; contro cui viene scagliato il titolo di «miserabile».
All’altro capo, «Dall’alto giù della china ripida» prende le mosse da un preciso e puntuale episodio, con tutta probabilità direttamente esperito. Si tratta del passaggio di una corsa ciclistica; sembra di capire, un gran premio della montagna seguito da una discesa in cui si getta un corridore in fuga.
Non per niente la successiva versione, compresa ne Il più lungo giorno s’intitola «Giro d’Italia in bicicletta» (sottotitolo «I° arrivato al traguardo di Marradi»); mentre un ulteriore rimaneggiamento del testo, destinato probabilmente ai Canti orfici, ma poi escluso dal volume, è posto sotto il segno del «Traguardo».
Il trattamento poetico di questo spunto aneddotico quotidiano-banale dai tratti spiccatamente moderni (è un avvenimento sportivo che non rientra tra gli argomenti canonizzati dalla tradizione), poteva dar luogo a diversi esiti: prima di tutto, se l’attualità fosse svolta e letterariamente ammantata in vesti auliche in essa scoprendo la "verità" del mito antico, ci si troverebbe nelle vicinanze dei «miti novelli» del D’Annunzio delle Laudi (del resto annoverato spesso tra le fonti campaniane); altrimenti, se Campana avesse calcato la mano sulla differenza tra linguaggio nobile e tema volgare ne sarebbe uscita una parodia, magari da "linea crepuscolare"; se, invece, avesse scomposto la scena nelle linee di forza motorie ne sarebbe venuto un testo futurista.
Tra queste, a prima vista, potrebbe sembrare che la scelta compiuta da Campana propenda per la mitizzazione di stampo dannunziano: infatti il punto di partenza concreto resta appena accennato (e ciò impedisce l’esplodere del contrasto parodico); piuttosto viene svolto in modo da ravvisarvi i termini di una «vita primeva»: i tifosi diventano le «turbe», la corsa è un «turbine», l’inseguimento del "gruppo" una scena di caccia («Come di fiera m caccia di dietro ti vola una turba»), la pedalata del ciclista è un «ritmo infaticabile» e il suo rush un «palpito indomo». L’esito di questo testo sarebbe dunque una piena trasfigurazione della realtà del mito?
Ma proprio là dove il mito apparentemente trionfa, con il nuovo finale aggiunto nella versione de II più lungo giorno, dove - e ben triplicato - risuona il peana alla divinità greca: «Dionisos Dionisos Dionisos», eppure in quella identificazione del dio con un anonimo cronachistico "girino" risalta una ben povera e avvilente epifania del dionisiaco; l’abbassamento l’ha vinta e vi scoccano scintille tra estremi.
Certo, lo smembramento bacchico non è minacciato dalla turba inseguitrice più di quanto non sia, intanto, praticato senza pietà nella sintassi del testo. Infatti il percorso delle varianti che conduce a «Giro d’Italia...» e poi a «Traguardo», va nel senso di una progressiva atomizzazione degli elementi che compongono le immagini e di un rimescolamento delle «schegge» secondo nuovi agglomerati semantici, con interscambio dei ruoli e delle qualità tra gli ambiti della scena, tra il corridore, la «turba» del pubblico, il «turbine» della corsa, e il paesaggio montano immobile.
È come se ognuna di queste parti si "oggettivasse" in un frammento da utilizzare come materiale da "costruzione". Ciò non va esattamente nel senso della ri-creazione mitica; piuttosto nel senso di una nuova configurazione allegorica a partire da un mondo ridotto in frammenti.
Ora, questa direzione futura che il testo sarà destinato a prendere, si trova anche come nucleo interno nella stesura prima. Abbastanza nascosta, ancora, a dire il vero, tuttavia situata in posizione nodale, nel cuore del componimento, di cui costituisce una sorta di "buco nero", di punto d’inciampo nello slancio vitalistico e conseguentemente nell’insorgere del mito. Intendo riferirmi a un verso alquanto eterogeneo rispetto all’insieme della scena che inserisce in essa tratti discordanti. Quando dopo
Bronzeo il tuo corpo dal turbineDiscende con lancio leggero
si dice:
Vertiginoso silenzio. Rocciosa catastrofe ardente d’intorno
L’intervento di due soggetti impersonali (e astrattizzanti) come il «silenzio» e la «catastrofe» porta la lama della contraddizione: nel «silenzio» è contraddetta la rumorosa esaltazione delle «turbe rideste» con tanto di «grido fremente», e precisamente la imperturbabilità della natura viene opposta a quella empatica partecipazione (e in essa alla stessa partecipazione al mito e al simbolo); dal canto suo la «catastrofe» pone sotto un segno rovinoso l’entusiasmo della prestazione sportiva - non solo: ma ne blocca il dinamismo immobilizzandolo nell’interna tensione di spinte e controspinte delle linee spezzate dell’ammasso roccioso (che sarà poi la «bolgia»).
È proprio questa, che potremmo definire con Benjamin, "inquietudine irrigidita", a venire in primo piano sempre più nelle successive stesure. Per giungere, in «Traguardo», a un finale del tutto diverso, giocato sul rallentato riassorbirsi che dalla spinta iniziale «Dall’alta ripida china» rientra infine nell’opacità delle "cose":
[...] (tra fuga lenta di grida le rocce)Rientrar! lo sguardo vertigine, brune.
Ma con questi versi e con la loro dedica a F. T. Marinetti, che interpreterei non come omaggio di vicinanza, piuttosto come lezione di una diversa (tensionale) nozione di "dinamismo"; con questi versi - dicevo - siano essi caduti dalla raccolta maggiore in base a criteri di valore oppure per altra ragione di natura non "estetica", comunque sia siamo già nell’area dei Canti orfici; là dove l’allegoria di Campana dispiega la sua azione "implicita" e capillare in tutta la sua complessità.