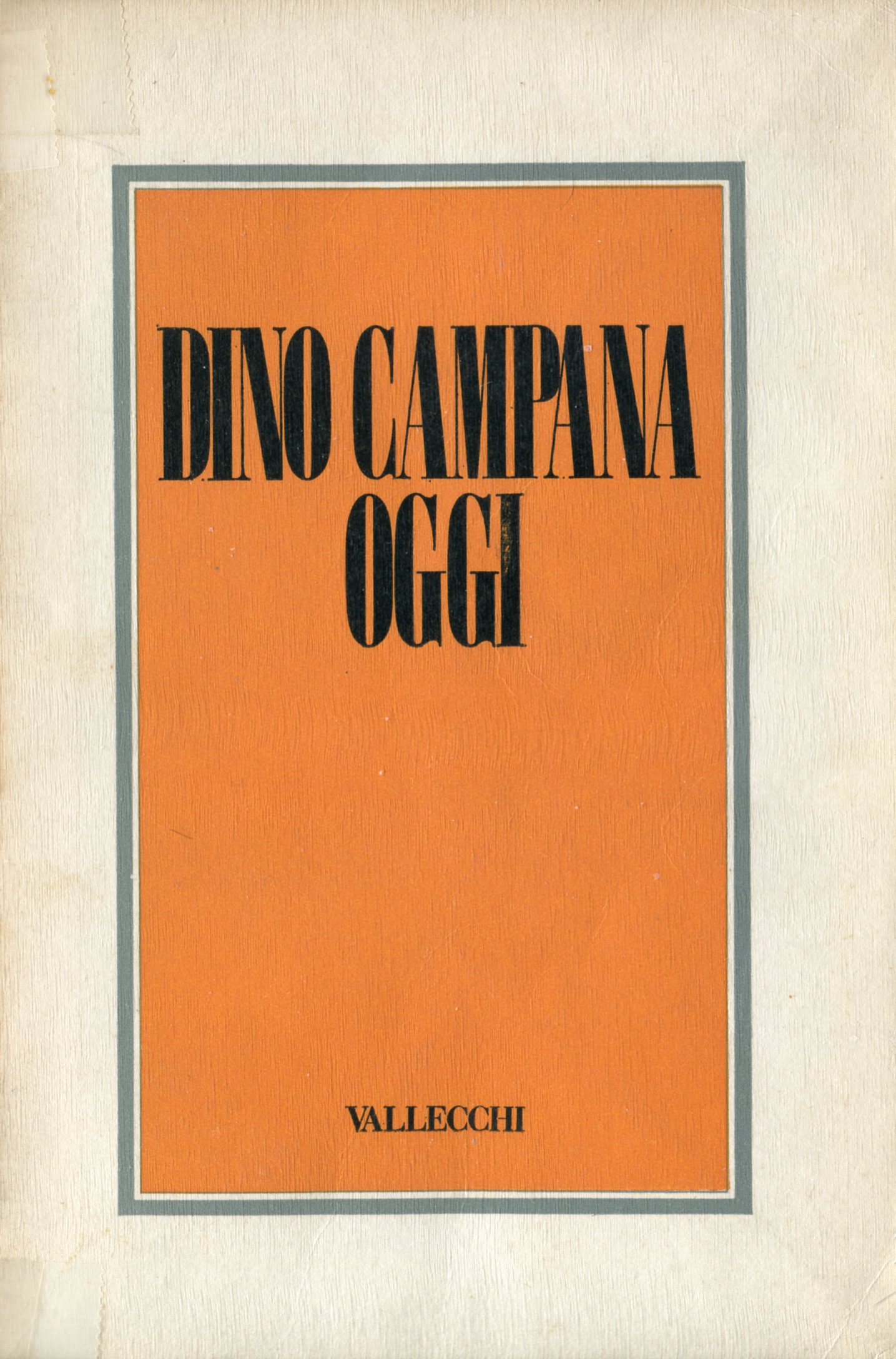
Dino Campana oggi
di Edoardo Esposito
Studi Novecenteschi, Vol. 5, No. 13/14 (marzo-luglio 1976), pp. 177-181
Recensione a:
Dino Campana oggi, Atti del Convegno di Firenze 18-19 marzo 1973, Firenze, Vallecchi, 1973, pp. X-166.
I temi più importanti del Convegno, come sottolinea Pampaloni nella prefazione, sono stati da una parte la discussione attorno al ritrovato manoscritto originario dei Canti orfici e dall'altra « il senso, l'immagine e il ruolo della poesia di Campana » (p. VII).
Sul primo motivo e centrato l'intervento di ENRICO FALQUI (Il manoscritto ritrovato, pp. 27-32), sostanzialmente uguale alla prefazione a II più lungo giorno di cui abbiamo già avuto modo di riferire (v. « Studi novecenteschi », n. 10, marzo 1975, p. 76); lo stesso dicasi per l'intervento di DOMENICO DE ROBERTIS (Per un più lungo giorno, pp. 33-49), più stringato e tecnico, però, nel commento a Il più lungo giorno e qui più diffuso, giuste le esigenze della « conferenza », più ricco di documentazione nel confronto dei vari testi campaniani, tra i quali indica come probabile archetipo, almeno in parte, sia del manoscritto de II più lungo giorno sia dell'edizione a stampa dei Canti orfici, il « fascicolo marradese » recentemente edito a Firenze (Giunti, 1972).
Più complessivo il discorso di apertura del Convegno, di CARLO BO (Nel nome di Campana, pp. 7-26), che tende a sottolineare la singolarità della figura di Campana e del suo travaglio poetico.
Si tratta, secondo Bo, del noto e « grande problema della coesistenza e della convivenza della poesia con la vita. Dicendo questo, siamo ben coscienti di spostare il tema critico su un terreno che non gli è proprio e in realtà sottraiamo Campana alla storia della poesia del suo tempo per farne qualcosa di più e che va molto al di là dei risultati accertabili e di tutte le soluzioni offerte.
E questo perchè siamo ugualmente convinti che — riportato nell'ambito di una valutazione letteraria — Campana non sarebbe nulla di più di un campione — illustre e eccezionale quanto si vuole — ma sempre un campione di un'opera non conchiusa, appena vagheggiata e bruscamente interrotta dalla follia » (p. 8).
Osserva quindi che « c'era in Campana una difficoltà estrema di conciliare i due momenti contrapposti della realtà e della sua accettazione » (p. 9) e che il suo irrequieto vagabondare non era appunto che il segno della sua impossibilità a comporli, anche o almeno poeticamente.
Questa ricerca a estremamente sincera e sofferta, mai letterariamente voluta, e porta Campana ad essere « un caso a sè e padrone di una lingua che non sarà mai di nessuno »; anche in questo senso a sbagliato riportare la sua opera alla « poetica del frammento » perche in lui « il frammento e il segno dello scacco, del fallimento, e il resto minimo della sua vocazione al canto » (p. 13).
Secondo Bo, « oggi Campana è diventato a sua volta un mito. Il mito del poeta che ribalta ilt mondo e lo inserisce in un movimento del tutto diverso, in un'altra natura delle cose, della realtà » (p. 19); un mito che rimane tale perchè la poesia si è servita del suo esempio ma ha preso strade diverse, ricollegandosi alla ragione e alla tradizione.
Occorre forse dire, a questo punto, che proprio una diversa scelta di Bo (più aderente a quel piano critico da cui ci si è voluti invece allontanare, secondo la dichiarazione vista all'inizio) avrebbe potuto contribuire a giustamente delimitare tale mito; più significative infatti di certe affermazioni (« la sua estraneità coincide con il senso della sua forza, il suo essere, il suo stare fuori della tribù gli attribuiscono una grazia che non dipende esclusivamente dal grado dei risultati nè dalla perfezione della sua parola », p. 23), e più utili ad una comprensione di Campana ci appaiono infatti quelle osservazioni critico-filologiche che Bo sa cogliere con finezza: « La ripetizione e l'insistenza sono due momenti caratteristici dell'ultima stagione poetica dichiarata e rappresentano da una parte l'impossibilità di alludere a un discorso significante e dall'altra la prova che il poeta stava per agganciare un nuovo modo di dire le cose » (p. 19).
Lo studio di NEURO BONIFAZI (L'elaborazione dei « Canti orfici », pp. 50-79) è volto a mostrare « la decisa maturazione che subì lo stile di Campana in quei pochi mesi (dall'inverno del '13 all'estate dell'anno successivo) » che vanno dalla perdita del manoscritto de Il più lungo giorno alla stampa dei Canti orfici.
Secondo Bonifazi proprio questa perdita offrì al poeta « da un lato, l'occasione di rimediare con altro animo e forse con altre letture al linguaggio delle sue composizioni, e dall'altro, lo stimolarono maggiormente a una revisione, che forse, se avesse avuto a disposizione il manoscritto perduto, sarebbe stata meno intensa e — almeno per certe correzioni non ricordate poi o non accettate — meno perfetta » (pp. 50-51).
Bonifazi osserva nel passaggio dall'una all'altra stesura un più moderato acquisto del contenuto, quale si rivela nell'eliminazione di alcune tracce vistose di derivazione culturale d'ogni genere [...] e, nell'aggiunta di altri 15 canti, anche di materiale misteriosofico » (p. 52); non cambiano comunque sostanzialmente le caratteristiche dell'opera: « Campana usa lt campo semantico del tempo (sera, giorno, crepuscolo) per indicare l'ansia nietzschiana di eternità, la rivolta contro il quotidiano, contro il giorno miserabile e la notte orrida della realtà scheletrica, per passare oltre a varcare in una dimensione atemporale, di un giorno prolungato, o più lungo, dove dalle cose stridenti si arriva al tutto » (p. 54); la sua tensione, nelle vari fasi ed esperienze espresse nella sua opera, e ad una « purezza originaria » e ad un « futuro di libertà » (p. 56).
Quanto alle modificazioni stilistiche, Bonifazi documenta con vari esempi ii lavoro di Campana, che porta in generale ad una maggiore fusione e armonizzazione del verso o della frase.
Due elementi in particolare vengono sottolineati: « il "che" relativo, posposto, quasi illogico ("tu ad un ignoto cielo notturno che avevi rapito ecc.", riferito al precedente "tu") » (p. 63) e « l'uso del "come" in funzione attenuativa, nel senso pressapoco di "quasi", per definire la superumana incertezza dell'apparizione, la volontà di una diversa realtà » (p. 66), quest'ultimo finora interpretato troppo spesso in senso comparativo. « Dentro il crepuscolo d'oro la bruna terra calando / Come una melodia »).
Conclude Bonifazi, dopo altre osservazioni ed esempi: « II rovesciamento di una figura di disordine, come è stata giudicata sempre quella di Campana (fino ai limiti del ribellismo, del teppismo e della pazzia) in immagine di ordinata poesia e di laborioso stile, se e — quindi — favorito da un collegamento con l'ideologia estetica del sogno artistico apollineo [...] e, inoltre, confermato dal lavoro poetico dello stile, di cui non disconosciamo la subliminare istintività, ma di cui affermiamo la riuscita realizzazione artistica» (pp. 77-78).
L'analisi e attenta e spesso chiarificatrice, ma mi sembra sopravvalutata l'azione correttoria del poeta, tanto che Bonifazi arriva ad affermare (sia pure in un ragionamento « per assurdo ») che, se essa fosse mancata « oggi non potremmo parlare di lui come del poeta che ha rinnovato lo stile poetico alle soglie del Novecento, e forse nemmeno di un grande poeta » (p. 52); credo, più modestamente, che occorra riconoscere le pur notevoli acquisizioni della stampa del '14 senza svalutare i risultati testimoniati dal ritrovato manoscritto; da una parte, infatti, i componimenti aggiunti nei Canti orfici presentano a volte le stesse « tracce vistose di derivazione culturale d'ogni genere » altrove eliminate (vedi Fantasia su un quadro d'Ardengo Soffici o Batte botte), e dall'altra la revisione non è tale che si giunga dovunque all'impedimento della complessa espressione campaniana.
SILVIO GUARNIERI (La sfida di Campana, pp. 80-85) sottolinea la tensione di Campana verso la vita e il mistero delle cose, il suo drammatico tentativo di carpirne il segreto e di esprimerlo nella sua poesia; testimone in questo di un'ansia e di una problematica caratteristica del suo tempo, in lui spinte fino « a provocare Ia follia proprio per questo suo sforzo di conquistare e di annettere all'uomo quel che sta al di la dell'umano » (p. 85).
Di difficile valutazione il saggio di MAURA DEL SERRA (Evoluzione degli stati cromatico-musicali, pp. 86-108), che tende ad un'analisi dell'evoluzione delle immagini dei Canti orfici: «un'analisi, cioè, della loro dissoluzione e ricostruzione continua, attuata prevalentemente attraverso processi analogici di tipo cromatico-musicale » (p. 88).
La Del Serra si richiama al « concetto europeo di Klangfarbe teorizzato da Kandinskij proprio in quegli anni: il colore che risuona musicalmente, in senso insieme psichico e spaziale, è usato infatti da Campana come un leitmotiv dinamico, vagamente surreale, e crea alla fine del brano un vero sipario musicale » (p. 94); per questo si sofferma a sottolineare le varie tonalità di colore delle pagine campaniane, cercando di coglierne i rapporti analogici con i diversi elementi che vi compaiono, e studiando insieme il succedersi delle aperture o delle concentrazioni delle immagini, intese anch'esse in senso musicale.
Ma l'analisi mi sembra a volte estremamente opinabile, e si veda per un solo esempio ciò che viene detto dei « piani spaziali di Faenza »: «Questi piani sono costruiti sull'immagine-guida della "grossa torre barocca", che percorre Ia prosa comparendovi tre volte in un arco iconico, all'inizio, a meta e alla fine.
L'arco è incorniciato da una sinestesia uditiva di tipo dinamico, come: "Nell'aria si accumula qualche cosa di danzante. Ascolto: la grossa torre barocca ora vuota mette nell'aria un senso di liberazione"; e anche da una rete di scorci cromatici dai toni solari (bianco, luce) che sono posti in dialettica coi toni sordi del rosso e dell'ombra » (p. 93).
Sarebbe qui almeno da notare che non viene sottolineata proprio una delle sequenze di immagini che più dovrebbe essere importante secondo l'assunto (e non solo) del-la Del Serra, e cioè il ricorrere della « ringhiera » e della « lampada »: « dietro Ia ringhiera una lampada accesa [...] una ringhiera corrosa [...] dietro la ringhiera colla piccola lucerna corrosa accesa ».
Ma soprattutto mi sembra eccessiva l'attenzione portata a certi dati e discutibile il rilievo concesso alla musicalità «in senso psicologico » (p. 88), in quanto il linguaggio ha (al contrario del colore kandinskijano) degli elementi concreti di musicalità, e su questi sarebbe dunque più opportuno puntare.
Il saggio appare cioè frutto di un attento esame e presenta una interessante documentazione, ma pecca forse proprio per la sua analiticità, in quanto i singoli dati non riescono poi ad essere adeguatamente organizzati e a fornire una sintesi interpretativa soddisfacente.
SILVIO RAMAT (Campana nella tradizione novecentesca, pp. 111-136) indaga la fortuna e il rapporto di Campana con la tradizione poetica novecentesca, osservando come fino al '28, anno della seconda edizione dei Canti orfici, a cura di Binazzi, più dell'opera avesse forse contato la figura dell'autore.
E' invece con la diffusione di questa edizione, e con il conseguente approfondimento critico, che l'opera assume adeguato rilievo, soprattutto in quanto viene corretta la primitiva lettura fortemente selezionatrice, tesa ad isolare i momenti più riusciti dal generalmente magmatico contesto, e si sottolinea invece la sua unità, il « libro come entità intricata ma compatta e organica » (p. 116), in cui « il positivo e il negativo paiono congiunti indissolubilmente » (p. 118).
E' in particolare da rilevare, secondo Ramat, che questo libro « giungeva a prospettarsi come assoluto, all'intelligenza letteraria degli anni Trenta, in virtù del proprio spessore d'ombra, della propria luce notturna, del suo irrisolto ritmo verticale — cioè abissale, nella doppia dimensione del gouffre che perde e dell'immedesimazione nel rito misterico "notturno" che salva » (p. 120).
Questi caratteri, che ricollegano l'opera di Campana ad influenze nietzschiane e in particolare elle tendenze simboliste, sono quelli the meglio permettono ai poeti nuovi di identificare in Campana il loro diretto antecedente; a sottolinearli sarà soprattutto Bo, in antitesi ad una lettura di Contini, che affermava Campana non « veggente » ma « visivo »; ma sono posizioni in cui, con opportune correzioni, quasi tutta la critica si riconoscerà e di cui paiono utile indicazione queste parole di Jacobbi, citate da Ramat: « Solo in Campana e con Campana la poesia prende il passo di quella compresenza della parole e dell'immagine reale, di quello sciogliersi di tutto l'uomo nel linguaggio, che è la suprema aspirazione dei moderni e che è stata poi provata e riprovata con alterne fortune nelle diverse formule della lirica pura, dell'orfismo appunto, della prosa d'arte quando si stacca dall'impressionismo e dal saggio, e finalmente, con più coerenza, dell'ermetismo. Parabola soggetta a tutte le crisi storiche [...] ma che rimane al centro dell'avventura eticoestetica del nostro secolo » (p. 132).
Alcuni esempi di scrittura di Gatto, di Bigongiari, di Parronchi, di Luzi, sottolineano ulteriormente i legami di certe forme e tematiche dell'ermetismo con la poesia di Campana.
Brevemente aneddotico l'intervento di GIUSEPPE RAIMONDI (Incontri bolognesi con Dino Campana, pp. 137-139). Quello di MARIO LUZI (Al di qua e al di là dell'elegia, pp. 140-146) tende invece a sottolineare la diversità della poesia di Campana « dall'ordine in cui si riconosce la tradizione moderna » (p. 140); rileva infatti che tipica della poesia moderna e la sua condizione di estraneità, il suo trovarsi in un territorio che « ritiene inabitabile perchè la progressione scientifica ed economica non ha sostituito alcun bene reale a quelli perduti con la rovina dell'umanesimo », per cui non resta al poeta che « testimoniare quel che il mondo non ha — mentre perdura nel-a penombra degli antefatti lo struggimento di un altro pensiero che dice: non ha più » (p. 141).
A questo « disinganno umanistico, Campana contrappone una variante sostanziale che è quella della complete integrazione dell'uomo nella vicissitudine del mondo, nella continuità e nella onnipresenza di tutta la vita » (p. 144).
Il che, secondo Luzi, non significa che i Canti orfici « diano come non avvenuta la lacerazione propria del poeta moderno, diviso tra la inesorabile fenomenologia del reale e l'incapacità di assimilarlo », ma che in essi siano piuttosto « risorse di umiltà e slancio che gli hanno consentito di ricucirla » (p. 145).
Stimolante infine, anche se limitato a pochi cenni, l'intervento di RUGGERO JACOBBI (L'esilio e la visione, pp. 147-156), per cui ii tema del viaggio, la volontà di mettersi in esilio, di andare a cercare un altro spazio [...] coincide — in quanto non sempre legato ad una realtà sperimentata, ma più spesso a memoria e fantasia — con la capacità visionaria di Campana » (p. 147).
Jacobbi, tralasciando la questione della realtà biografica dei viaggi del poeta, su alcuni dei quali avanza però alcuni dubbi, rileva infatti come nella pagina di Campana l'immagine prevalga spesso sul vissuto, vi si confonda e risalti a volte nettamente.
Così egli applica una espressione quasi identica a due città diverse come Firenze e Genova, o unisce sempre al sostantivo « musica » lo stesso aggettivo, « fanciulla », testimoniando il suo interno trascendere il dato materiale verso un'idealizzazione che ci rivela, come in questo secondo caso, le sue segrete aspirazioni: il desiderio di purezza e di innocenza che è quello stesso sotteso al viaggio, il tendere ad « una città futura, la città degli uomini liberi, un luogo vergine, un luogo senza storia » (p. 151).
Di qui la suggestione della nave o del porto, che rappresentano un tema continuo in Campana (e che si mescola a volte, nota Jacobbi, con una « dimensione più concreta dell'esilio », quella forse più realmente vissuta, a contatto con la « folla degli straccioni, degli emigranti italiani »., p. 153), e che, nella visione di un mondo nuovo e intatto, si ricollegano a Whitman, l'autore dell'epigrafe posta a chiusura dei Canti orfici, nonchè alla fuga dall'Europa di Rimbaud: « In Rimbaud, nel suo sogno del terzo mondo, agisce la rabbia dell'antico comunardo: in Campana non c'e nulla di simile. Ma il moto interiore e analogo: tentazione, o illusione, di andarsene in un mondo senza storia, in un mondo tutta natura » (p. 151).
